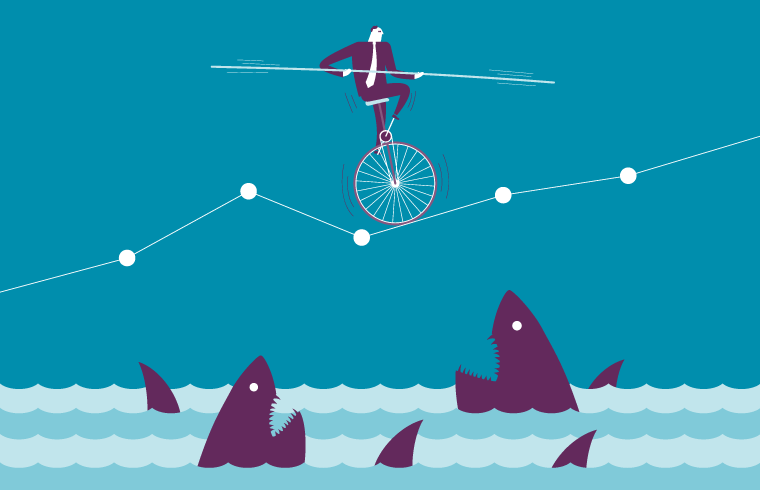
Hate speech e brand-hate. Cosa danneggia davvero l'impresa?

Quando dovresti cambiare una comunicazione prodotto che va bene

Sei pronto ad usare Instagram per parlare di valori?
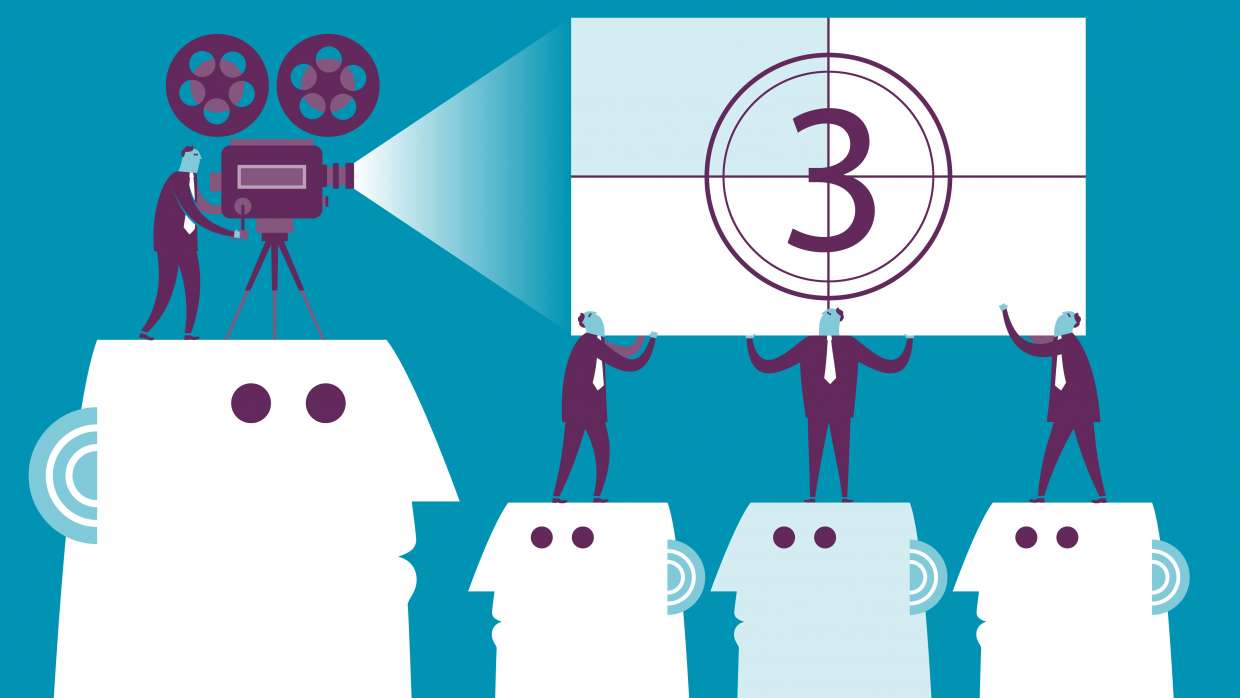
L'autoreferenzialità è il male assoluto della comunicazione?

Armi di distrazione di massa nelle mani delle imprese

Come i bias cognitivi inducono le startup a raccontarsi usando i fake